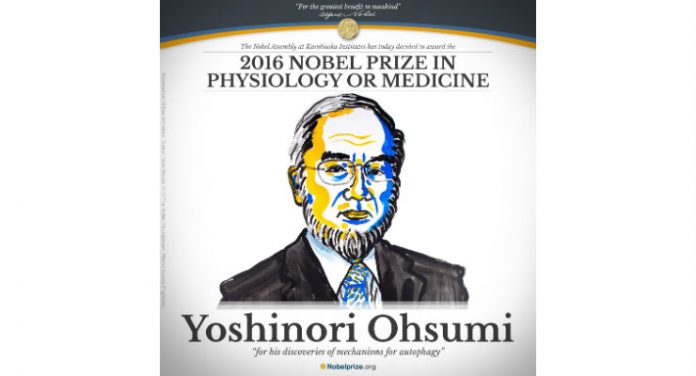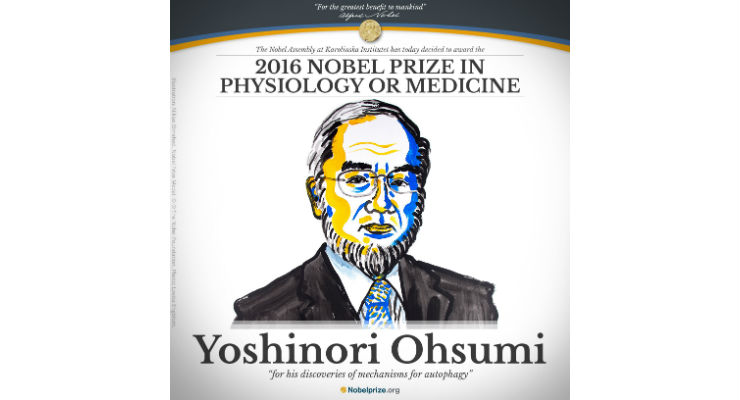
Yoshinori Ohsumi, giapponese, classe 1945, professore al Tokyo Institute of Technology. È lui il premio Nobel per la Medicina e la fisiologia del 2016, riconoscimento che Ohsumi porta a casa per aver scoperto e chiarito il meccanismo dell’autofagia, il processo cioè di degradazione e riciclo dei componenti cellulari. Come, è lo stesso nome a suggerirlo: nutrendosi di sé, mangiandosi.
La scoperta risale agli anni Novanta, quando Ohsumi condusse una serie di esperimenti sul lievito che gli permisero di identificare i geni e i meccanismi fondamentali dell’autofagia. Ma la storia della scoperta di Ohsumi trova traccia però almeno negli anni Cinquanta, in un’altra scoperta avvenuta in quel tempo, quella del lisosoma, premiata, neanche a dirlo, con un Nobel, nel 1974.
Il lisosoma è un organello, ovvero uno dei tanti componenti dispersi all’interno della cellula, che funziona come una stazione di smaltimento e riciclo. Analizzando questi organelli infatti i ricercatori nel tempo si accorsero che contenevano dei componenti cellulari e che esisteva un meccanismo preciso con cui questi componenti raggiungevano i lisosomi: il materiale che finiva in questi organelli veniva come impacchettato, all’interno di piccole vescicole ribattezzate autofagosomi. Fu lo stesso Nobel del 1974 a parlare di autofagia, per descrivere il processo. Identificato questo sistema di trasporto eccezionale restava da capire: a cosa serve? Come avviene? Potrebbe servire a smaltire altri organelli ormai consumati o grossi componenti proteici?
Per rispondere alle domande ancora aperte Ohsumi si concentrò sullo studio dei lieviti, cercando prima di tutto di capire se anche in questi organismi – tra i modelli più utilizzati in biologia – fosse presente il meccanismo dell’autofagia. Per farlo il ricercatore pensò di bloccare l’azione di alcuni enzimi necessari per l’attività distruttiva dell’analogo nel lievito dei lisosomi (il vacuolo) ma stimolando al tempo stesso l’autofagia (affamando la cellula). L’idea era: se blocco qualcosa a valle vedrò cosa accade a monte.
Ohsumi si accorse così che nel giro di poco tempo una serie di vescicole si accumulavano nel vacuolo, rendendosi ben visibili. Si trattava di autofagosomi, e le osservazioni del ricercatore giapponese dimostravano che l’autofagia esisteva sì anche nel lievito. Ma non solo: continuando a lavorare sul lievito, inducendo mutazioni genetiche e autofagia, Ohsumi negli anni a seguire riuscì a chiarire la cascata di eventi che determina l’autofagia e i diversi protagonisti. Non passò molto prima che divenne chiaro che meccanismi simili funzionano anche per gli altri organismi viventi. Il lavoro del neolaureato premio Nobel permise di mettere insieme un quadro dunque accennato anni prima, riuscendo a capire come da segnali che innescano l’autofagia, avvenga il meccanismo che permette la formazione degli autofagosomi e quindi la loro distruzione nel lisosoma. Perché il lisosoma funziona come un piccolo intestino: contiene enzimi per distruggere ciò che arriva da quelle parti.
Una scoperta non da poco, considerando cosa fa e cosa permette di fare l’autofagia. Come meccanismo di riciclo l’autofagia consente di recuperare materiale e ed energia per il rinnovamento dei componenti cellulari, di smaltire complessi proteici e organelli danneggiati, di eliminare virus e batteri garantendo così la sopravvivenza (in salute) della cellula in casi di stress (come la mancanza di nutrienti), invecchiamento o attacco da parte di agenti infettivi. Non è un caso infatti che alterazioni del processo o mutazioni a carico dei geni essenziali per l’autofagia si riscontrino anche in diverse patologie, dal Parkinson, al cancro.
Via: Wired.it