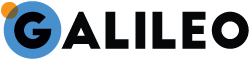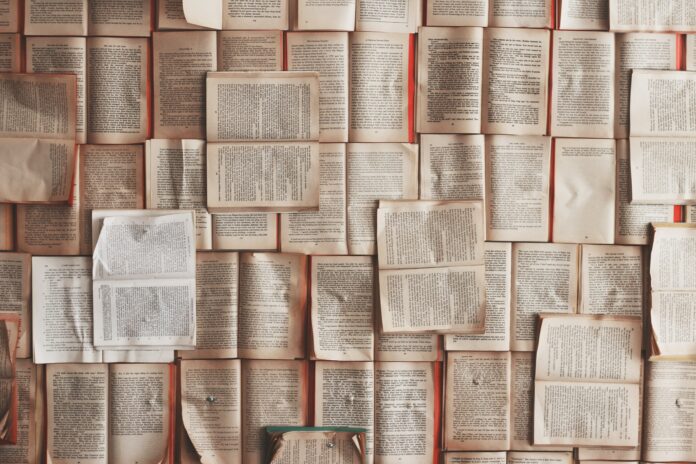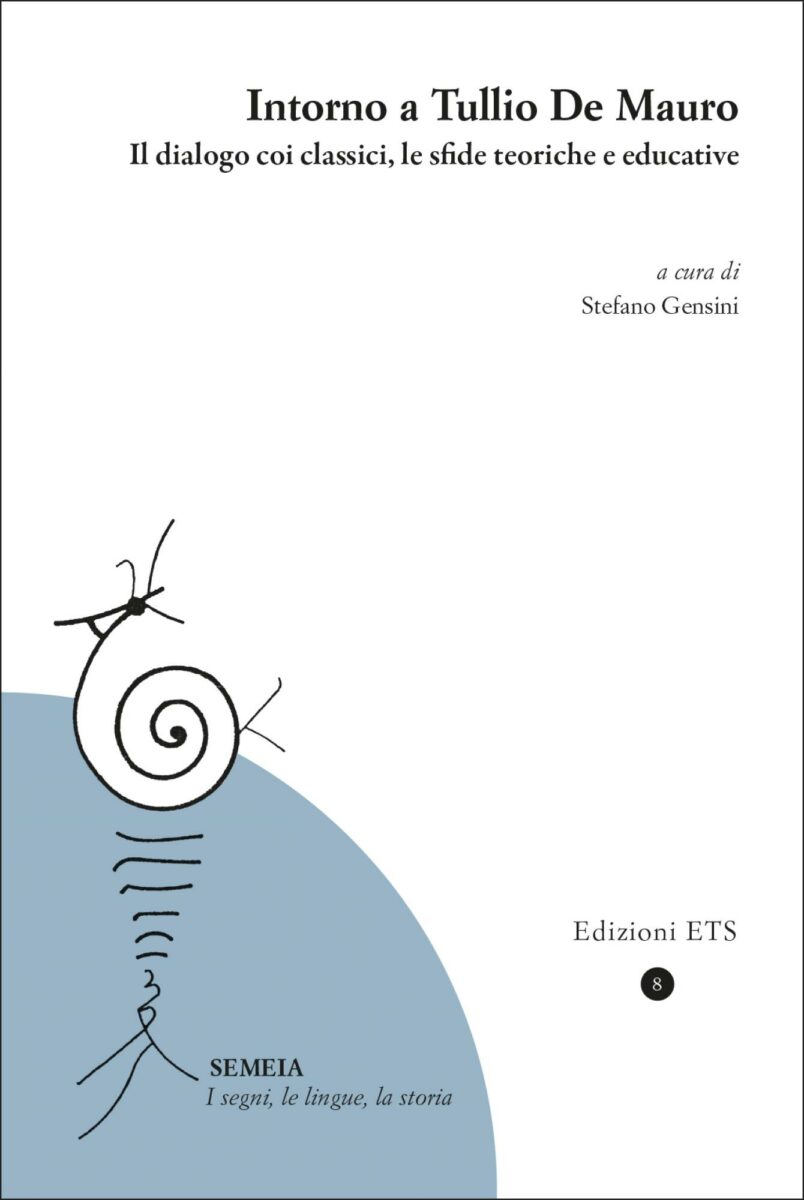Questo libro raccoglie saggi di diversi autori che, da specifici punti di vista, mettono in evidenza aspetti della personalità di Tullio De Mauro, uno studioso che ha lasciato una traccia profonda nel modo contemporaneo di guardare alla filosofia del linguaggio e ai suoi risvolti educativi e sociali. De Mauro propone infatti una concezione evolutivamente dinamica del linguaggio, rielaborando e sviluppando le idee del suo maestro, il glottologo Antonino Pagliaro, rimodulando le impostazioni teoriche di Ferdinand de Saussure (e di Noam Chomsky), del Wittgenstein successivo al Tractatus, di Benedetto Croce e di Vygotskij, aperto al pensiero di Gramsci come a quello di don Milani. L’importanza delle idee di Saussure è fondamentale per De Mauro che com\unque costruisce, a partire da queste solide basi, le sue innovative e personali teorie che mettono in particolare evidenza la variabilità e la plasmabilità della lingua in funzione della esplicitazione del significato che il parlante vuole comunicare. Nei suoi studi esplora quindi tanto gli aspetti creativi quanto quelli riproduttivi della lingua, cioè quelli innovativi e quelli culturalmente legati alla memoria e alle precedenti esperienze. Come ricorda Grazia Basile, infatti, la disponibilità alla variazione semantica è per De Mauro di volta in volta necessaria affinché i parlanti possano comprendersi tra loro, saggiando nelle diverse circostanze l’estensibilità delle parole fino a coglierne un senso nuovo e diverso rispetto agli usati.
La parola instabile
Proprio l’attenzione al significato rappresenta, secondo Stefano Gensini, l’aspetto filosofico più interessante nel pensiero di Tullio De Mauro, sviluppato in una sorta di dialogo con Saussure ma che al di là delle relazioni tra langue e parole è teso a mettere sempre meglio in evidenza il carattere radicalmente sociale e storicamente contingente delle strutture linguistiche. La parola, quindi, ha una sorta di identità instabile, determinata più che dal suo significato ontologico e logico dalla interazione in atto tra i parlanti in quel preciso contesto.
Il Glotto-Kit
Rifacendosi ad alcuni aspetti innovativi del pensiero di Vygotskij, De Mauro ha partecipato alla sperimentazione sviluppata negli ‘80 del 1900 presso le Scuole Comunali dell’Infanzia di Scandicci, in un team composto da pedagogisti dell’Università di Torino e da fisici dell’Università di Roma. La ricerca voleva mettere in evidenza le relazioni tra le attività pratiche dei bambini a scuola e l’elaborazione linguistica sviluppata tra gli adulti e i coetanei in quel contesto sociale: i risultati hanno permesso al suo team l’elaborazione del Glotto-Kit, uno strumento per la programmazione di interventi didattici capaci di promuovere nei docenti la curiosità conoscitiva verso il plurale mondo linguistico dei propri allievi (M. Vedovelli, 1984).
Le sperimentazioni a scuola
Riprendendo Wittgenstein, l’interesse verso i modi di parlare come espressione dei modi di vivere ha portato Tullio De Mauro a valorizzare il lavoro educativo di Don Milani, a sostenere le associazioni impegnate nella formazione degli insegnanti come l’MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), il CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) il GISCEL (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica) con cui definisce le Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica. Sempre ragionando sulla creatività del linguaggio in funzione del bisogno comunicativo e, più in generale, sulla specificità regionale dei dialetti, De Mauro dà forma al suo pensiero sul lessico come regno della variazione nel GRADIT, il Grande dizionario italiano dell’uso. La situazione culturale italiana e le differenze nei livelli di possesso delle capacità alfabetiche, le distanze dalla lingua-norma nelle diverse situazioni di sottosviluppo impegnano De Mauro a occuparsi di scuola fino ad accettare l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione e a definire nuovi programmi per l’insegnamento nella scuola elementare (rapidamente aboliti dalla ministra del successivo governo).
Il linguaggio della burocrazia
Come ricorda Marco Maurizi, il problema del reciproco intendersi tra i parlanti è sempre stato cruciale per De Mauro, la cui attenzione al “significato” ha sempre voluto evitare il solipsismo linguistico, la solitudine del parlante, e sfuggire così al pericolo della incomunicabilità sempre presente nella relazione linguistica. Così il saggio di Michela Piattelli mette in evidenza l’esigenza della comprensibilità nel linguaggio giornalistico, come in quello burocratico o in quello scientifico, per essere capiti da un pubblico più o meno ampio caratterizzato da rilevanti differenze nella padronanza linguistica. Gli scritti giornalistici di De Mauro non hanno il compassato e spesso oscuro stile della stampa quotidiana della sua epoca, tendendo piuttosto alla chiarezza e alla semplicità di una lingua che si avvicinasse all’italiano parlato. Del resto, gli intellettuali italiani, da Pasolini a Calvino, da Citati a Barbato dibattevano “le nuove questioni linguistiche” lamentando la mancanza di una lingua omologatrice comprensibile ai più e lontana da quella usata di solito nei giornali, vaga e sfuggente, ricca di vocaboli incomprensibili.
Ripensare i libri di testo
Per concludere con un ricordo personale, coerente con i temi trattati in questa raccolta di saggi, sono indimenticabili le lunghe discussioni con De Mauro per modificare e rendere accessibile ai ragazzi il linguaggio dei libri di testo per le scuole elementari e medie, in particolare di quelli scientifici. Costruire l’accordo tra comprensibilità e scientificità sembrava fondamentale per elevare il livello di competenza scientifica dei ragazzi e interessarli a quello che stavano studiando. Ma editoria e scuola hanno le loro regole, pare, e gli stimolanti suggerimenti di De Mauro non ne hanno mai potuto far parte.
Foto di Patrick Tomasso su Unsplash