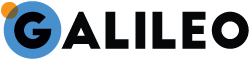La peste bubbonica non fu la causa delle gravi epidemie che si susseguirono a partire dal Medioevo. E’ quanto sostiene un gruppo di antropologi della Penn State University di Washington. Dopo aver analizzato documenti e registri ecclesiastici che annotavano la presenza di una grave epidemia verificatasi in Inghilterra nel 1350, i ricercatori hanno concluso che in base alla virulenza, alle dinamiche geografico-temporali di diffusione, e alle stesse cause scatenanti, non si trattava di peste bubbonica.
In quel periodo la cosiddetta Morte nera si manifestò con una mortalità tra i sacerdoti 45 volte superiore alla media, nessun documento inoltre riportava notizie di morie di topi, il principale veicolo di diffusione della peste bubbonica. I ricercatori hanno ipotizzato dunque un tipo di contagio per contatto, come avviene per il morbillo o il vaiolo, ma non per la peste.
Anche i sintomi riscontrati, come febbri altissime, tosse, ingrossamento delle ghiandole, emorragie dalla pelle e vomito ematico, sono comuni a diverse malattie. La peste bubbonica inoltre non ha tempi di diffusione molto rapidi, perché il contagio passa all’uomo (spillover) attraverso pulci o insetti solo dopo aver raggiunto nei topi un’elevata frequenza. In genere colpisce aree limitate, perché i fiumi o i canali navigabili circoscrivono il movimento dei roditori e, quindi, il contagio.
Quale fu allora la causa della Morte nera? I ricercatori americani ipotizzano che si poteva trattare di un agente microbico che successivamente si sarebbe evoluto in quello della peste bubbonica. (p.f.)