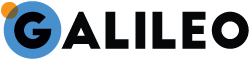Per sopravvivere, il cervello umano deve evitare l’abitudine e dare la priorità a ciò che è nuovo e diverso: se succede qualcosa di sorprendente o di inatteso quest’organo risponde con grande intensità. Quando tutto è prevedibile, invece, risponderà di meno e qualche volta non risponderà affatto. Il libro scritto dalla neuroscienziata Tali Sharot e da Cass R. Sunstein, studioso di Economia comportamentale, mette in evidenza con numerosi esempi come l’abitudine – che i due autori chiamano abituazione – comporti l’inibizione attiva fra neuroni diversi e quindi la mancanza di risposte alle cose che non cambiano.

L’abitudine toglie il piacere
Le sorprese rendono felici (di solito!) mentre l’abitudine toglie il piacere a esperienze che la prima volta ci sono sembrate eccitanti. E’ possibile evitare l’abituazione? Le pause, consigliano i ricercatori, riducono la tendenza ad adattarsi, ed anche una breve vacanza può innescare la disabituazione evitando, nei casi più critici, di entrare in depressione. Alcuni cercano la varietà, e sono elettrizzati dalla prospettiva del nuovo; altri temono invece gli orrori di un cambiamento disastroso che, soprattutto se improvviso o non programmato, può generare tensione o disagio. Eppure, nell’arco di pochi mesi, la maggior parte delle persone si adatta alla nuova situazione, alla nuova città come al nuovo lavoro o alla nuova casa, e in molti casi finisce per essere riluttante a tornare indietro. E’ difficile valutare a priori cosa succederà nella nostra mente, ma le statistiche dimostrano che, dopo breve tempo, le persone che temevano di soffrire sono in realtà felici come quelle che accettavano o desideravano il cambiamento.
Non rinunciare ai cambiamenti
Una ricerca svolta tra studenti sottoposti a un periodo di prova difficile e indesiderato ha messo in evidenza che la temuta esperienza già dopo una settimana si dimostrava meno dolorosa, e alla quarta o quinta settimana non veniva più percepito alcun disagio. Saper prevedere l’abituazione, scrivono gli autori, è dunque molto importante, per non lasciarsi spaventare e non rinunciare per questo a possibili cambiamenti di vita. Trovarsi in un ambiente del tutto nuovo, per esempio, invita a trovare nuove soluzioni possibili e aumenta la flessibilità del pensiero, mentre l’abituazione la riduce. In ogni caso, dalle indagini dei due scienziati risulta l’importanza per tutti di perseguire uno scopo per la vita, e spesso la gioia di dare agli altri provoca meno abituazione della ricerca della felicità per se stessi.
L’abitudine alla menzogna
Tra i numerosi esempi presentati, gli autori esplorano le tante situazioni in cui il cambiamento provoca benessere, documentando l’incredibile resilienza dello spirito umano e i tanti modi in cui per esempio, durante la pandemia, le persone si sono impegnate a rendere sempre più piacevole il loro ambiente per accettare il nuovo modo di vivere. La creatività rappresenta una risorsa fondamentale, e la fantasia è un ingrediente assai utile. Ma quando questa porta ad alterare completamente la realtà e ad entrare nel regno della menzogna ecco che devono scattare sistemi di allarme. Ci si può abituare a mentire, ed è molto importante intervenire in tempo per disabituare i bambini alla menzogna. Infatti la cosiddetta “erosione etica” che inizia gradualmente con una serie di trasgressioni minori si può poi stabilizzare in modo definitivo. Ci si può abituare anche al rischio, proseguono gli autori, e questo porta il cervello a stimare il pericolo in misura sempre minore, e ad allontanarsi sempre più da elementari norme di sicurezza. Avendo sempre meno paura si prendono sempre meno precauzioni, ed anche in questi casi il cambiamento, il rimescolare le carte può attivare una utile disabituazione.
Abitudine e pregiudizi
L’ultima parte del libro, forse la più interessante, analizza i tanti casi in cui l’abituazione ci impedisce di rilevare antichi pregiudizi e di accorgerci di quanto e come certe situazioni sociali siano cambiate. Per esempio, si continua ad usare con indifferenza un certo tipo di linguaggio senza notare che, al giorno d’oggi, questo è veramente discriminante o offensivo, razzista o maschilista. Se ne accorgono invece le persone che non sono completamente abituate, quelle che gli autori chiamano imprenditrici della disabituazione, e che sono pronte ad agire nella direzione che ritengono giusta. L’esempio di Rosa Parks o i testi di Betty Friedan hanno stimolato la disabituazione in ampi contesti sociali. Queste “imprenditrici” smuoveranno inizialmente persone disponibili a cambiare ma che hanno bisogno di qualcuna da seguire, e queste a loro volta saranno seguite da altre, e poi da altre ancora, mentre quelle che sono perfettamente abituate non si ribelleranno in alcuna circostanza. La speranza è quella di aumentare la consapevolezza delle persone sulle catene formate dalle abitudini e dai pregiudizi per dare loro la voglia e la possibilità di spezzarle.
Il ruolo della tecnologia
Gli autori concludono ricordando quanto la percezione di una situazione e la capacità di valutarla dipendono da cosa è prevalente in quel momento: dando socialmente importanza a cose (o valori) diversi cambia di conseguenza anche il modo di percepirli. Incontri con persone, tradizioni e modi di vita nuovi cambiano il genere di realtà in cui siamo abituati e le moderne tecnologie, che faranno sempre più parte del nostro quotidiano, potranno diventare “macchine di disabituazione” capaci di offrirci nuove prospettive sul mondo.
Foto di hayleigh b su Unsplash