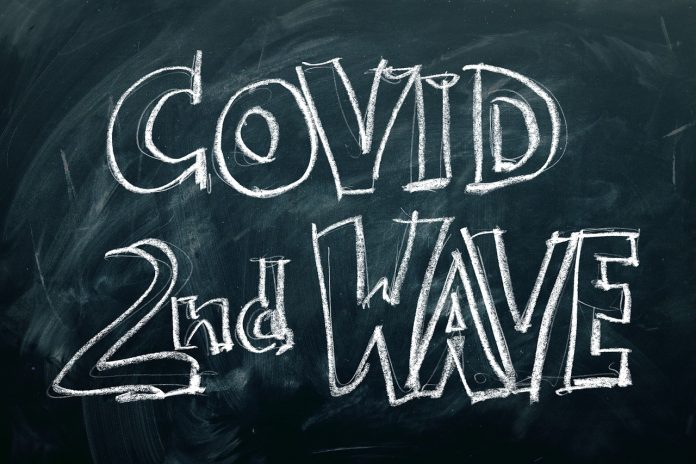L’ennesimo Dpcm di queste settimane non manca di far discutere, e per molti motivi. Ad iniziare dalla creazione delle ormai celebri zone rosse, arancioni e gialle, che quantomeno per il prossimo mese segmenteranno la penisola in regioni a maggiore, o minore, rischio epidemico. Passando ovviamente per il coprifuoco serale delle 22:00. Per arrivare alla fantomatica didattica a distanza o Dad, nuovo acronimo pandemico con cui si sancisce, nei fatti, le chiusure delle scuole, subordinata a differenze di ordine e grado, e al bollino epidemico regionale. Su quest’ultimo punto, in particolare, si combatte da tempo una battaglia serrata, che vede scienziati, ministri e politici dividersi sulle opposte barricate a dispetto di colori politici e ruoli istituzionali: chi vorrebbe chiuderle senza troppi complimenti come il nervosissimo governatore della Campania Vincenzo De Luca, e chi (come la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina) ritiene essenziale tenerle aperte fin quando possibile. A mesi dall’inizio di questa pandemia, la scienza ha un’idea precisa del ruolo che hanno le scuole alla diffusione di Covid 19? Non esattamente: gli ultimi dati in letteratura sembrano rassicuranti, ma come molte altre, anche la gestione delle scuole rimane per ora una scelta politica, che deve necessariamente scegliere come bilanciare i rischi della pandemia e quelli, non meno concreti, legati alla dispersione scolastica, al ritardo educativo, e ai rischi psicologici a cui vanno in contro bambini e adolescenti con il protrarsi del loro isolamento sociale.
I dati ci sono?
Per iniziare, una premessa è d’obbligo: il modo migliore per valutare il ruolo delle scuole nella diffusione dell’epidemia sarebbe chiaramente verificare quanti focolai hanno ospitato dalla riapertura di settembre, e quante persone sono state contagiate come conseguenza. Il problema è che questi dati non ci sono. O meglio: il ministero giura di averli, ma per ora ha deciso di non renderli pubblici. Con una nota della scorsa settimana il Miur ha assicurato di aver condivido i dati relativi al monitoraggio Covid nelle scuole italiane con l’Istituto superiore di sanità, e tant’è. Con buona pace della trasparenza vantata a più riprese dal governo, per ora non si può che fidarsi dei numeri snocciolati nelle scorse settimane dalla ministra Azzolina, che parlano di 5.793 studenti, 1.020 insegnanti e 283 appartenenti al personale non docente risultati positivi dall’inizio del monitoraggio. E di un numero di focolai scolastici che nella settimana tra il 12 e il 18 ottobre rappresentavano appena il 3,5% di quelli registrati nel paese dalla riapertura delle scuole. Numeri consolanti, che descrivono però uno scenario fermo alla prima metà di ottobre, e ci obbligano quindi a scavare più a fondo nella letteratura scientifica per cercare qualche indizio dei rischi che comporta realmente la didattica in presenza nel mezzo di questa pandemia.
La ricerca italiana
Una delle pochissime ricerche sulle scuole italiane è stata realizzata dall’immunologa Antonella Viola e dal biologo Enrico Bucci. I due scienziati hanno utilizzato i dati disponibili sui giornali per stimare il numero di infezioni avvenute nelle scuole di Bergamo, Milano e del Lazio, e integrato la loro analisi con lo studio delle curve epidemiche regionali in corrispondenza della riapertura delle scuole. Stando ai risultati, l’incidenza di infezioni in ambiente scolastico sembrerebbe sovrapponibile a quella della comunità.
Le scuole, quindi, non sarebbero un elemento che contribuisce a moltiplicare i contagi, né avrebbero al contempo alcuna forma particolare di protezione dal virus, ma rifletterebbero semplicemente la situazione epidemica della società che le circonda. Un istituto scolastico è quindi solamente uno dei tanti possibili luoghi dove ci si può contagiare, al pari di bar, ristoranti, posti di lavoro. La conclusione dei due scienziati è che non ci sono motivi per suggerire la chiusura delle scuole, o quanto meno, non ve ne sono più di quanti ve ne siano per invocare più in generale un lockdown dell’intera società.
Lo studio che preoccupa
Sul fronte opposto troviamo invece una ricerca pubblicata su Lancet Infectious Diseases da un team di ricercatori dell’Università di Edimburgo. Presentata da molti media italiani come uno studio sulla pericolosità delle scuole, la ricerca nasceva in realtà per valutare l’efficacia dei principali interventi restrittivi presi in giro per il mondo sulla riduzione dei contagi. Tra quelli analizzati, la chiusura delle scuole risultava il secondo più efficace, con una riduzione media dell’Rt (l’indice di diffusione del virus) pari al 15%, e un aumento pari al 24% in corrispondenza delle riaperture.
Come è stato sottolineato da più parti (e dagli stessi autori dello studio) questa ricerca presenta però diversi limiti quando si prova a interpretare i suoi risultati. Uno su tutti, la difficoltà che esiste nel districare gli effetti di più provvedimenti, come il blocco della mobilità, la chiusura degli uffici pubblici e privati, introdotti contemporaneamente e in aree del mondo differenti tra loro come l’Africa, l’Europa, l’Asia o gli Stati Uniti.
L’analisi ai primi di ottobre
Un altro studio italiano (per ora in preprint) ha tentato di verificare, per quanto possibile, l’impatto della riapertura delle scuole sulla curva dei contagi di Covid. Anche in questo caso, in mancanza di dati ufficiali i ricercatori del Gemelli di Roma hanno dovuto fare affidamento sui giornali per raccogliere informazioni sui focolai scoppiati in ambito scolastico.
I dati raccolti parlano di 1.350 casi di infezione nelle scuole al 5 ottobre, e di un numero totale di focolai pari a 1.212 su oltre 65mila scuole presenti sul territorio italiano. Dei 1.059 studenti positivi emersi nello studio, 236 erano studenti di asilo e materna, 300 delle elementari, 208 delle medie e 452 dei licei. Particolare importante, nel 90% dei casi i contagi si sono limitati ad uno per scuola. Un dato che sembrerebbe indicare un basso rischio di trasmissione in ambito scolastico.
Indizi sulla contagiosità nelle scuole
Se di studi epidemiologici per ora non possono che essercene pochi, un altro modo per valutare i rischi connessi alle scuole è senz’altro quello di indagare la suscettibilità dell’infezione da Sars-Cov-2 nei bambini e nei ragazzi. Sappiamo infatti che i più giovani hanno minori rischi di sviluppare una malattia sintomatica, e una probabilità praticamente nulla di soffrire di sintomatologie gravi.
Questo vuol dire che sono anche più resistenti all’infezione, e hanno quindi minori probabilità di contagiarsi tra loro? Certezze (ormai dovremmo esserci abituati) ancora non ce ne sono, ma una serie di indizi sembrano indicare che le cose stiano proprio così. Una metanalisi inglese pubblicata su Jama Pediatrics, effettuata analizzando 32 ricerche internazionali, ha concluso ad esempio che i giovani di età inferiore ai 20 anni hanno una probabilità di infettarsi con Covid inferiore del 44% rispetto agli adulti, anche se non ha potuto stabilire se è vero anche il contrario, cioè se i giovani hanno minori probabilità di infettare gli adulti. Questa sorta di resistenza all’infezione è risultata inoltre più alta prima dei 14 anni, ed è forse questo dato a guidare le chiusure, come quella italiana, limitate ai licei.
A livello di popolazione, uno studio realizzato in Australia (dove molte scuole sono rimaste aperte anche durante il picco epidemico) ha concluso inoltre che bambini e ragazzi non contribuiscono in modo rilevante alla diffusione del virus, e che le scuole non sembrano quindi un moltiplicatore importante di infezioni. Risultati simili arrivano anche da uno studio coreano, che ha analizzato la proporzione di infezioni secondarie attribuibili ai bambini in famiglia (quanti adulti sono stati infettati dai piccoli di casa), concludendo che i bambini non sono un driver rilevante in questa epidemia, a differenza di quanto ci hanno abitato a credere altre malattie respiratorie come l’influenza. Risultati del genere sembrano quindi indicare che i più giovani hanno non solo minori probabilità di ammalarsi di Covid, ma anche minori rischi di infettarsi e di trasmettere a loro volta il virus. Uno scenario che renderebbe le scuole luoghi tutto sommato sicuri, soprattutto con il rispetto delle precauzioni (mascherine e quant’altro) imposte nel corso degli ultimi dpcm.
Il modello dell’Imperial College
Per concludere, passiamo a uno studio sulle scuole più difficile da interpretare, che offre però alcuni spunti interessanti sulle possibili strategie di contenimento dell’epidemia. Tre fisici dell’università di Edimburgo hanno infatti deciso di replicare i risultati del modello epidemiologico utilizzato dall’Imperial College a marzo per prevedere i possibili esiti dell’epidemia in termini di decessi e carichi sanitari. Lo stesso preso in considerazione anche qui da noi durante quei primi mesi caotici, e che ha spinto i governi di mezzo mondo ad adottare il lockdown in risposta all’incessante espansione dell’epidemia. Non avendo a disposizione il modello originale, i ricercatori di Edimburgo hanno utilizzato Covidsim, un modello epidemiologico pubblicamente accessibile realizzato dallo stesso team di ricercatori dell’Imperial College. Il nuovo tentativo di replicare lo scenario di diffusione del virus in Gran Bretagna ha confermato nuovamente uno dei risultati meno intuitivi del modello originale. La chiusura delle scuole sarebbe infatti efficace nel ridurre il picco di pazienti in terapia intensiva, ma con un piccolo effetto collaterale: aumentare il numero di morti sul lungo periodo.
La spiegazione? È presto detto: rallentando la diffusione del virus tra le fasce più giovani della popolazione si prolunga la durata dell’epidemia (ovviamente in assenza di vaccini e della reintroduzione periodica di misure di contenimento), e il risultato sul lungo periodo è quello di un’epidemia più lunga, e di un numero maggiore di vittime. Si tratta, è chiaro, di scenari del tutto ipotetici, e già affrontati dagli epidemiologi dell’Imperial College, che infatti hanno sempre proposto lockdown intermittenti come soluzione, in attesa di terapie e vaccini in grado di modificare drasticamente la circolazione del virus.
Evitando di dare troppo peso ai risultati di un singolo studio (per di più basato su uno scenario epidemico probabilmente irrealistico, e realizzato con un modello epidemiologico che ha ricevuto pesanti critiche negli scorsi mesi), la lezione che si può trarre da questa ricerca è forse che tenere aperte le scuole fin quando possibile non ha solo effetti benefici sui bambini e i ragazzi, come sottolineato ultimamente dallo stesso comitato tecnico scientifico, ma potrebbe persino avere effetti positivi sull’evoluzione dell’epidemia, ampliando la platea di cittadini non più suscettibili all’infezione, e velocizzando così la risoluzione della crisi quando (si spera) arriveranno finalmente farmaci e vaccini in grado di arrestare efficacemente la corsa di Covid-19.
Via: Wired.it
Leggi anche su Galileo: Covid-19, cosa fare in caso di contatto stretto con una persona positiva
Scuola online ai tempi del Covid-19: quello che non funziona
Credits immagine: Maximilian Scheffler on Unsplash