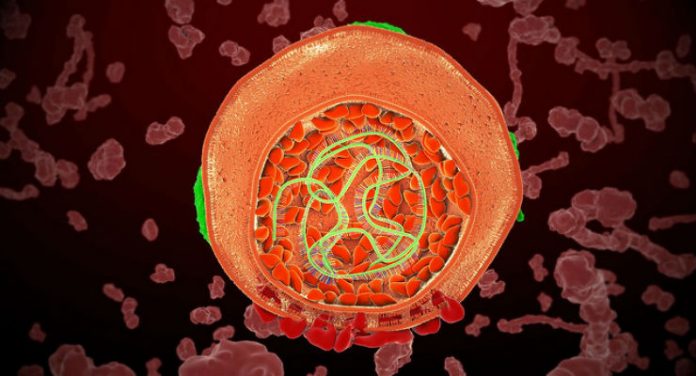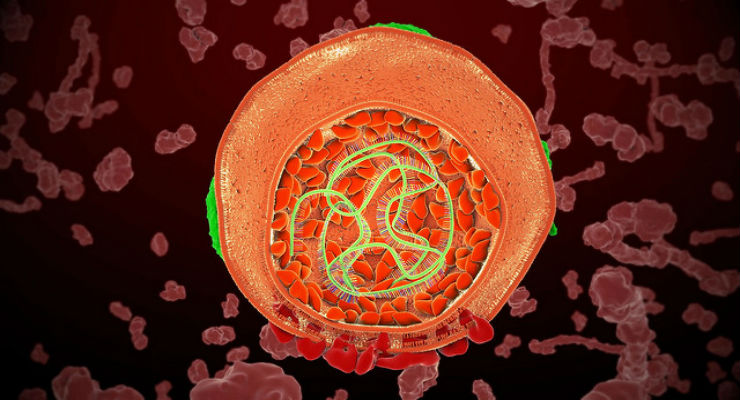
Alix Poulot/Flickr CC)
È successo tutto nel giro di 27 anni. Dal non avere un nome – prima del 1989 l’epatite C era solo epatite non A e non B – si è passati a parlare di eradicazione. È possibile, ci si chiede, immaginare, se non il mondo, almeno l’Europa libera dall’Hcv nei prossimi anni? Entro il 2030, come chiede il Manifesto per l’eliminazione di questa infezione? La risposta che si respira all’International Liver Congress in corso a Barcellona sembra essere sostanzialmente un sì. Al di là di tutti gli ostacoli che ancora rimangono e non senza condizioni.
Se è vero infatti che l’arrivo dei (costosi) antivirali di seconda generazione (direct-acting antivirals, DAAs) ha cambiato la storia di questa malattia, a lungo gestita a suon di interferone, ribavirina (con tutti i pesanti effetti collaterali), e trapianti di fegato (senza escludere affatto il rischio di re-infezione) ancora oggi a essere trattati sono in pochi. Anche perché molti non sanno neanche di essere infettati dal virus.
Ma i malati sono tanti: 150 milioni quelli che convivono con l’infezione cronica da Hcv nel mondo, 15 milioni in Europa. Una quota imprecisata in Italia: dai 200 mila a un milione (tanti, si crede, ignari), con un numero di morti che arriva, si stima, a diecimila. Ma il numero di pazienti italiani che hanno avuto accesso ai nuovi antivirali continua a crescere: 42 mila nell’ultimo aggiornamento rilasciato dall’Agenzia italiana del Farmaco. Sebbene non per tutti i nuovi antiretrovirali rappresentino una soluzione.
Infatti, malgrado l’altissimo tasso di SVR (sustained virologic response, l’assenza di virus rivelabile nel sangue, una misura dell’efficacia della terapia) raggiunto grazie alle terapie con i nuovi antivirali, per circa il 5% dei pazienti i DAAs non funzionano, ovvero non riescono a curare. E per questi, al momento, nuove opzioni di trattamento sono limitate. “Uno dei problemi che abbiamo con un regime terapeutico cui risponde oltre il 90% delle persone è studiare la parte che rimane per capire perché in queste le terapie falliscono”, spiega Stefano Fagiuoli Direttore Unità complessa di gastroenterologia, epatologia e trapiantologia ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Per queste persone, che hanno sviluppato ceppi resistenti o parzialmente resistenti a combinazioni di farmaci, dovremmo mettere in atto strategie basate non più sulle convenzionali combinazioni di farmaci disponibili sul mercato ma cercare nuove combinazioni”. Secondo una serie di regole guida, spiega Fagiuoli: “Di base si usa il sofosbuvir, si aggiunge la ribavirina per aiutare la risposta e quindi uno o più farmaci di una classe che non confligga con la classe per cui si è sviluppato resistenza, o nuove molecole”.
Ed è questa una delle direzioni in cui si stando andando per i nuovi approcci clinici all’epatite C, come emerge dal congresso, dove sono stati presentati i risultati relativi a queste nuove combinazioni di antivirali, efficaci per i diversi genotipi (sono sei in tutto quelli del virus Hcv) nella ricerca guidata da Eric Lawits dell’University of Texas Health Science Center.
Lo studio ha riguardato 128 pazienti non responsivi a terapie anti-Hcv (interferone pegilato, ribavirina o diversi DAAs) che per 12 settimane hanno ricevuto una nuova combinazione tripla di antivirali sofosbuvir/velpatasvir e GS-9857, un composto sperimentale, con o senza rivabirina. Nel complesso il 98% dei pazienti ha raggiunto SVR a 12 settimane. “Il nostro studio dimostra che per i pazienti con Hcv nei quali i trattamenti precedenti con DAAs hanno fallito questa combinazione tripla porta a un alto tasso di risposta virologica sostenuta in tutti i genotipi di Hcv”, ha commentato Lawitz: “Ma non solo, lo studio indica anche che la combinazione di trattamento è generalmente sicura e ben tollerata dai pazienti, fornendo così un’alternativa per chi soffre di Hcv con limitate opzioni di ri-trattamento”.
Riferimenti: The International Liver Congress