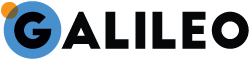Federico Taddia e Telmo Pievani
Perché siamo parenti delle galline? E tante altre domande sull’evoluzione
Editoriale Scienza 2010, pp. € 11.90
Galline, scimpanzé, iguane ghiotte di cactus e pesci che se ne stanno rintanati per millenni sul fondo dell’oceano finché qualcuno non li scova. E ancora, uccelli elefante, dodo, insetti che ingurgitano bruchi vivi e macachi che salano le patate in mare perché non gradiscono i cibi sciapi: sono questi, e tanti altri, i protagonisti della straordinaria avventura della vita, che Federico Taddia e Telmo Pievani ci raccontano con un garbo e un’ironia davvero irresistibile. Le simpatiche illustrazioni di Roberto Luciani non sono un semplice accessorio, ma stuzzicano la fantasia e agevolano l’apprendimento, rendendo questo agile testo ancora più gradevole. E tutto è all’insegna della piacevolezza, perfino la consistenza della carta patinata e il suo odore che ricorda i banchi di scuola.
Sono davvero tante le scoperte che si possono fare anche semplicemente sfogliando questo nuovo volume della collana “teste toste” che, come veniamo avvertiti nella prefazione, si può leggere dall’inizio alla fine ma anche dalla fine all’inizio, o a pezzettini, che forse è il miglior modo perché consente di assecondare l’istinto e la curiosità. Possiamo comunque affidarci all’indice, che si propone di fare un po’ d’ordine tra tanti stimoli, o, ancor meglio, alle domande che troviamo in calce alle pagine e che ci offrono un po’ di suspance rinviando altrove per le risposte. Non dimentichiamo poi di raccogliere la sfida di p. 4 a porre noi stessi delle domande che troveranno spazio sul sito dedicato al libro. Insomma, la maieutica oramai si allea alla tecnologia, e il libro diventa interattivo.
“Perché siamo parenti delle galline?” piacerà senz’altro ai ragazzini curiosi ma delizierà anche gli adulti, che leggendolo impareranno un sacco di cose. Per esempio, lo sapevate voi che i dinosauri erano animali agili ed eleganti, e che alcuni di loro indossavano perfino penne e piume variopinte? Ce li immaginavamo goffi e rudi, rivestiti da una pellaccia verde e senza maniere, e invece spesso si trattava di veri gentlemen, che avevano perfino una vita sociale. Ma le sorprese non finiscono qui. Anche gli animali che vivono ai nostri giorni e che credevamo di conoscere bene hanno dei segreti che proprio non ci saremmo aspettati. Prendiamo le ghiandaie: ve lo aspettereste che riescono a ricordarsi la posizione esatta di migliaia di semi? O i delfini. Oggi li vediamo saltellare beati tra le onde e non sospetteremo mai che un tempo avessero le zampe e camminassero sulla terraferma. Eppure è proprio cosi, i mammiferi marini che amiamo tanto si sono tuffati in acqua soltanto dopo che la selezione naturale ha favorito gli esemplari che avevano le zampe più simili alle pinne. La storia della vita è in continua evoluzione e anche l’essere umano non è sempre stato come è oggi, né sempre lo sarà. Migliaia di anni fa eravamo alti appena un metro, e i topi, che allora misuravano 80 centimetri, ci arrivavano all’altezza delle spalle. A proposito, sapevate che siamo parenti più stretti dei topi che dei cani? E’ proprio cosi, nell’albero della vita i roditori occupano una posizione più vicina all’essere umano rispetto al cane, che pure se è nato lo deve proprio a noi, e al suo antenato lupo, che ha accettato di darci fedeltà in cambio di cibo, e cosi a poco a poco ha acquisito i caratteri di quello che sarebbe diventato il nostro più fedele amico. L’amico più fedele, quindi, non il parente più stretto. Questo ruolo spetta invece alle scimmie. E’ incredibile quanto alcune specie possano assomigliarci. Gli scimpanzè, per esempio, portano in braccio i piccoli e gli insegnano a usare oggetti proprio come noi umani. I bonobi, poi, sembrano più sensibili e pacifici di quanto tendiamo a esserlo noi: cercano soluzioni cooperative ai problemi e si consolano a vicenda per un lutto o una sconfitta.
Nell’anno internazionale della biodiversità un libro come questo non avrebbe potuto non ricordare la storia delle tante specie che si sono estinte con lo zampino scellerato dell’essere umano, dal bradipo gigante al lupo delle Falkland. Nella lista dei cari estinti c’è naturalmente dodo, che con i suoi 20-30 chili di tenera carne bianca è finito sulle tavole degli olandesi. Per fortuna troviamo anche storie più allegre, come quella del celacanto, un pesce che si credeva estinto sin dall’epoca dei dinosauri e che invece è stato ritrovato qualche decennio fa mentre se la spassava nell’Oceano Indiano. E poi ci sono le storie ancora da scrivere, come quella della clonazione del mammut. Oggi far rinascere l’antico pachiderma non richiederebbe un grande sforzo: basterebbe prelevare il suo Dna dai ghiacci polari, dove si è ben conservato, e trasferirlo in un elefante. E chissà se non sarebbe contento, il vecchio mammut, di tornare a vivere in mezzo a noi. Una cosa è certa: la scienza ci permette di realizzare imprese straordinarie, offrendoci possibilità che fino a ieri sarebbero state semplicemente impensabili. Di qui anche il monito a fare buon uso dei poteri che abbiamo a disposizione. Più che far rinascere nuove specie, per esempio, sarebbe più opportuno impegnarci perché sopravvivano quelle a rischio. O anche cercare di conoscerle meglio, visto che ne esistono di milioni di cui neppure sospettiamo l’esistenza, e che sono, in fondo, nostre parenti.
Insomma, si tratta di un libro da consigliare a tutti i maestri che temono la noia, perché vi troveranno mille spunti per insegnare divertendo, e, soprattutto a chi, cedendo a smanie oscurantiste, ha ancora voglia di mettere in discussione la teoria dell’evoluzione. Perché su un punto almeno gli autori sono categorici: Darwin aveva ragione. «L’albero della vita, la discendenza comune, il succedersi delle specie nei miliardi di anni di antichità della terra: sono certezze, come è certo che la terra gira intorno al sole» (p. 24). Sul grado di parentela possiamo anche discutere, ma non c’è dubbio che siamo parenti delle galline. Chissà, forse oggi ne sapremmo di più se Mendel e Darwin si fossero incontrati, ma pur vivendo nella stessa epoca, i due illustri scienziati erano troppo diversi. Mentre il primo se ne stava quieto quieto nel suo monastero a studiare i piselli, l’altro se ne andava a zonzo per il pianeta a scovare le specie più strane e sconosciute. Un incontro mancato, il loro. Un incontro ben riuscito, invece, quello tra Federico Taddia, comunicatore di professione, e Telmo Pievani, filosofo della scienza, che hanno dato vita a un testo in cui il potere delle risposte non oscura mai il fascino delle domande.
Un’ultima nota. Dicevo che i due autori sono categorici sulle ragioni di Darwin. Ma forse non è ben detto, a meno che con “ragioni di Darwin” non intendiamo anche lo spirito di tolleranza e il valore della diversità sottesi alla prospettiva dell’evoluzione. E allora è meglio specificare altri due punti su cui gli autori sono altrettanto categorici: «le razze umane non esistono» (p. 43) e «siamo i primi immigrati di tutti i tempi» (p. 9). Si, perché il nostro comune progenitore non è l’uomo di Neanderthal che se ne stava a casa propria ma l’homo sapiens che dall’Africa si è spostato in Asia e in Europa.