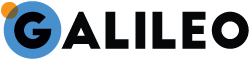La lunga latitanza del virus dell’epatite C sta per finire. A dieci anni dall’individuazione del codice genetico dell’Hcv, è finalmente chiaro come avviene l’infezione. Nei laboratori dell’Istituto di ricerche Chiron di Siena, l’équipe guidata da Sergio Abrignani, direttore del Dipartimento di immunologia, ha scoperto dopo tre anni di lavoro la porta di ingresso che permette al virus di legarsi alle cellule umane per infettarle: è la molecola-recettore CD81. La scoperta, i cui risultati sono stati pubblicati sull’ultimo numero della rivista Science, apre finalmente la strada alla comprensione del ciclo vitale del virus, accelerando la messa a punto di un vaccino e lo sviluppo di nuove terapie.
La speranza di trovare una cura per l’epatite C è forte, visto che la malattia colpisce il 3 per cento della popolazione mondiale, cioè circa 170 milioni di persone. In Italia i malati toccano quota due milioni, che corrispondono al 2 per cento della popolazione. “Si tratta purtroppo di cifre sottostimate – afferma Abrignani – e il numero dei contagiati potrebbe essere più alto perché l’infezione è quasi sempre asintomatica e si manifesta quando i danni al fegato sono ormai in fase avanzata”.
Nel 50-60 per cento dei casi l’epatite C evolve nella forma cronica che a sua volta si può complicare con la cirrosi epatica, ed eventualmente con il cancro del fegato. L’evoluzione lenta e silenziosa della malattia ostacola le cure e l’astensione dai comportamenti a rischio. Debellato il pericolo trasfusioni con i test di screening, l’incidenza di epatite C si è ridotta e oggi l’infezione si trasmette generalmnte attraverso piccolissime quantità di sangue infetto, come può avvenire per esempio in ambiente medico, dal dentista, dal manicure, con i tatuaggi, nei rapporti sessuali e ovviamente con lo scambio di siringhe. L’unica terapia per ora a disposizione è l’alfa interferon, efficace tuttavia solo nel 20 per cento dei casi. In circa la metà delle persone trattate con questo farmaco antivirale, migliorano i sintomi, che riprendono comunque alla sospensione della terapia.
Finora nessuno era mai riuscito a osservare il virus al microscopio elettronico, ne’ tanto meno a farlo crescere in laboratorio. L’unico segnale era l’aumento nel sangue di anticorpi specifici e la presenza dell’acido nucleico virale, l’Rna, rilevabile con la Pcr, una tecnica molto sofisticata con cui è possibile evidenziare e amplificare sequenze di acidi nucleici. Mancava però un particolare: come entra l’Hcv nella cellula? In che modo vi si aggancia? I ricercatori italiani hanno cercato di chiarirlo in questi tre anni. “Utilizzando tecniche di biologia molecolare – spiega Abrignani – già in passato avevamo prodotto la proteina principale che forma l’involucro dell’Hcv, la E2. Il secondo passo è stato dimostrare che l’E2 si aggancia alle cellule di linfoma e di epatocarcinoma umano, ma non a quelle di topo. Ciò ha confermato il fatto che sui lifociti B e sulle cellule del fegato umano doveva necessariamente esistere un recettore specifico per l’Hcv. Per identificarlo abbiamo quindi trasferito il Dna delle cellule di epatocarcinoma umano in quelle di topo, che hanno così acquisito la capacità di legare l’involucro del virus. A questo punto era chiaro che il gene che conferiva la capacità di legare l’Hcv codificava per la molecola CD81, un recettore che nell’uomo viene sintetizzato oltre che dalle cellule del fegato anche dai linfociti B”.
La scoperta che il CD81 è il recettore dell’Hcv è importante perché accelererà lo sviluppo di nuovi farmaci e di un vaccino anti- epatite C, studi finora rallentati dal fatto che l’unico modello di infezione con Hcv era lo scimpanzé, specie animale protetta e costosissima. “Ora che abbiamo smascherato il bersaglio del virus, – continua Abrignani – sarà possibile disegnare nuovi farmaci che ostacolano l’ingresso del virus nelle cellule umane. Inoltre, disporremo presto di un piccolo modello animale, il topo, su cui poter sperimentare rapidamente i candidati vaccini. Questi studi saranno condotti su topi transgenici, in grado di esprimere il CD81 umano e, si spera, di essere così infettati dall’Hcv”.
Se tutto va bene questa scoperta anticiperà lo sviluppo di un vaccino anti-Hcv di almeno un paio d’anni. Un vaccino sperimentale è peraltro già in prova nell’uomo dall’inizio di quest’anno e si attendono i risultati definitivi sulla sua efficacia fra 3-4 anni. Sempre tra due anni dovrebbe partire anche la sperimentazione clinica di nuove sostanze che bloccano l’entrata del virus interferendo nel legame virus-recettore CD81.