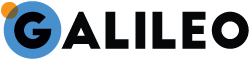La sentenza condanna i predecessori, gli attuali si dimettono. I sei anni in primo grado a Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Bernardo de Bernardinis, Giulio Selvaggi, Claudio Eva e Gianmichele Calvi, componenti della commissione Grandi rischi ai tempi del terremoto che colpì L’Aquila nel 2009, hanno avuto come prima conseguenza le dimissioni a ruota dei vertici (e non solo) della commissione stessa.
Prima è stato l’attuale, meglio ex, presidente ad andarsene, il fisico Luciano Maiani, e a seguire sul tavolo di Mario Monti sono arrivate anche le dimissioni del presidente emerito Giuseppe Zamberletti e del vicepresidente, Mauro Rosi. Ma anche Mauro Dolce, tra i condannati, si è dimesso da capo dell’ufficio rischio sismico e vulcanico della Protezione civile (che risponde alla Grandi rischi), così come Roberto Vinci, direttore dell’ Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), tra i membri della Commissione. Le motivazioni le ha spiegate Maiani: “Ritengo che la situazione creatasi a seguito della sentenza sui fatti dell’Aquila sia incompatibile con un sereno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione e con il suo ruolo di alta consulenza nei confronti degli organi dello Stato”.
Ma se le dimissioni della Grandi Rischi sono state la conseguenza primaria della sentenza, ci si chiede ora che cosa comportino a loro volta le defezioni di massa dalla commissione. È la stessa Protezione civile a rispondere, lanciando l’allarme: il rischio è una “paralisi delle attività di previsione e prevenzione”.
Perché a essere in pericolo è il ruolo stesso della commissione, struttura di collegamento tra Protezione civile e comunità scientifica cui spetta la funzione principale di: “fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacita di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi”. Per farlo, la commissione agisce in cinque diversi ambiti: rischio sismico, rischio vulcanico, rischio meteo-idrogeologico, idraulico e di frana, rischio chimico, nucleare, industriale e trasporti e rischio ambientale e incendi boschivi, avvalendosi per ciascuno di un gruppo di esperti.
Come scrivono dalla Protezione civile: “È facile immaginare l’impatto di questa vicenda su tutti coloro che sono chiamati ad assumersi delle responsabilità in questi settori considerati i pilastri di una moderna Protezione civile. Il rischio è che si regredisca a oltre vent’anni fa, quando la protezione civile era solo soccorso e assistenza a emergenza avvenuta. Oppure che chi è incaricato di valutare finisca per alzare l’allerta al massimo livello ogni qualvolta i modelli previsionali forniscano scenari diversificati, generando una crescita esponenziale di allarmi che provocheranno assoluta sfiducia nei confronti di chi li emette o situazioni di panico diffuso tra la popolazione”.
Con le dimissioni dalla Commissione, sindaci e istituzioni dovranno prendere decisioni a tutela dei cittadini in caso di rischi senza poter contare sui pareri e le valutazioni degli esperti, che “che da oggi non si sentono più tutelati dal Paese per cui prestano servizio”, scrivono ancora dalla Protezione civile. Perché oggi quegli scienziati non se la sentono più di fornire i propri pareri, come ha dichiarato alle agenzie Zamberletti: “Il rischio è che gli scienziati non se la sentano più di esprimere liberamente il risultato delle proprie conoscenze. Che garanzie hanno che gli studi fatti non possano diventare oggetto di una responsabilità penale? Questo non avviene in nessuna parte del mondo. Il problema è riuscire a dare una normativa che, salvo i casi di dolo o di grave negligenza o colpa, tuteli la ricerca. Adesso si è creato il terrore: se gli esperti esprimono un parere e c’è la minaccia di un procedimento penale, si perde serenità nel giudizio. Ci sono restrizioni che possono frenare la libera ricerca”.
Via: Wired.it
Credits immagine: emiliano_design/Flickr