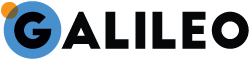Oliver Sacks non ha bisogno di molte presentazioni. Il suo libro “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” ha probabilmente fatto conoscere al grande pubblico le neuroscienze, e ha indirettamente contribuito a migliorare la vita di molti malati e delle loro famiglie, facendogli capire che non erano i soli a dover convivere con malattie che, anche se non curabili, potevano essere rese meno invalidanti e vissute con maggiore qualità.
In questo “Musicofilia”, che non per nulla nell’edizione originale inglese ha come sottotitolo “storie di musica e del cervello”, Sacks raccoglie diversi casi di interazione tra la mente umana e la musica. Già il concetto stesso di musica, se ci si pensa un po’ su, è davvero strano. In effetti, non si capisce a priori perché gli umani siano così attratti dalla musica, salvo rarissime eccezioni che sono considerate patologiche: l’amusia è una malattia proprio come l’afasia, anche se quest’ultima è molto più nota.
La musica in testa
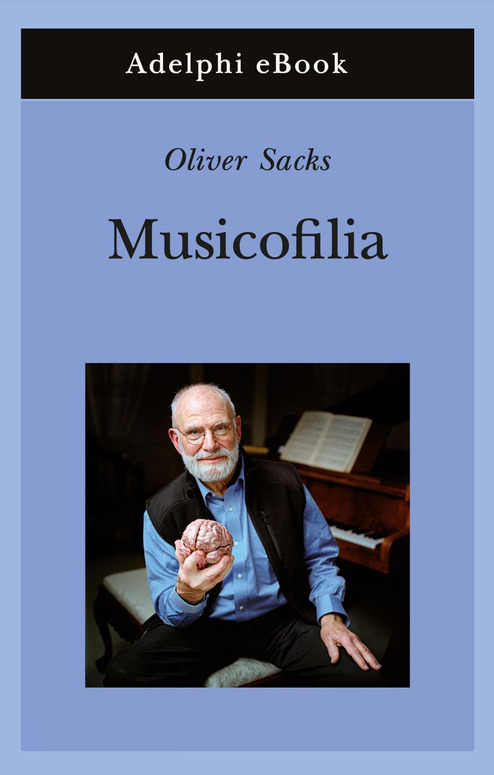
Nel libro non si trattano solo le malattie legate in qualche modo alla musica: per esempio, il primo caso presentato è quello di un medico che, dopo essere stato colpito da un fulmine, sviluppò un improvviso e fortissimo interesse per la musica, tanto da mettersi non solo a suonare ma addirittura a comporre. Altri casi di studio presentati sono quello dell’orecchio assoluto, che permette di riconoscere una nota senza doverla sentire in riferimento a un’altra, e quello dell’orecchio sinestetico, molto più raro, che associa a una nota musicale, oppure a un accordo, un colore. Nel caso dell’orecchio assoluto, vengono fatte delle ipotesi speculative sulla possibilità che sia una capacità innata nei neonati, ma venga perduta per facilitare la comprensione delle parole; in effetti questo capita soprattutto nelle lingue non tonali, come l’italiano, dove ogni sillaba ha un significato indipendentemente dal tono con cui viene pronunciata. Il cinese mandarino, invece, è una lingua tonale e infatti la percentuale di cinesi dotati di orecchio assoluto è maggiore, per esempio, di quella degli statunitensi.
La parte principale del libro è però dedicata alle malattie degenerative e non del cervello, e alle possibilità date dalla musicoterapia. Scopriamo quindi che pazienti col morbo di Parkinson trovano giovamento da una musica ritmica che permette loro di essere più sciolti e liberi nei movimenti; oppure che ci sono persone assolutamente incapaci a parlare ma che possono cantare brani della loro gioventù senza alcun problema. Addirittura ci sono persone affette dal morbo di Alzheimer capaci di imparare e ricordare nuovi brani musicali, anche se la loro memoria episodica e a volte persino quella remota, è gravemente compromessa. La musica, insomma, riserva moltissime sorprese, gran parte delle quali non ha ancora trovato una spiegazione.
L’unico appunto da fare al libro, oltre a un paio di sviste di traduzione, è che spesso Sacks riprende casi che aveva già trattato nelle sue opere precedenti; un lettore affezionato, e non particolarmente interessato ai temi musicali, potrebbe perciò trovare più di una traccia di déjà vu.
Il libro
Oliver Sacks
Musicofilia
Adelphi 2008, pp. 434, euro 23,00