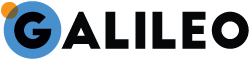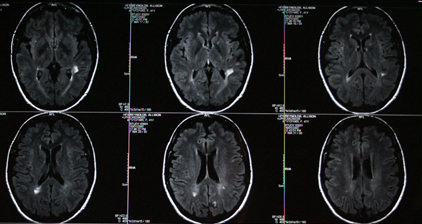Lo studio clinico per verificare l’associazione tra la sclerosi multipla e la CCSVI (insufficienza venosa cerebro-spinale cronica), finanziato dall’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e che coinvolge oltre 40 centri italiani, è partito anche presso il Centro Studi Sclerosi Multipla dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (vedi Galileo). Ma è polemica sulla formazione dei sonologi che effettueranno gli esami, sui tempi richiesti per verificare la correlazione tra le due patologie e sul ritiro dallo studio di Paolo Zamboni, il professore dell’Università di Ferrara che per primo ha ipotizzato il nesso. Galileo ne ha parlato con Massimo Del Sette, neurosonologo della Divisione Neurologia dell’Ospedale Civile S. Andrea di La Spezia, presidente della Sinec (Società italiana neurosonologia ed emodinamica cerebrale) e uno dei tre esperti che analizzeranno i 2.000 esami dello studio epidemiologico. Del Sette è infatti tra i coordinatori del comitato scientifico dello studio dell’Aism. Ecco, allora, come avviene la formazione degli operatori che effettuano le analisi e quali sono le differenze tra la ricerca epidemiologica promossa dall’associazione e un secondo studio – “Brave Dreams” – promosso dalla Regione Emilia Romagna e disegnato da Zamboni, che partirà a breve.
Professor Del Sette, può riassumerci i punti fondamentali dell’esame diagnostico?
“La diagnosi di CCSVI viene fatta secondo i criteri definiti dal professor Zamboni e pubblicati nei suoi primi lavori. Inoltre, verranno eseguite anche altre analisi della emodinamica cerebrale sulle vene sia extra sia intracraniche; queste analisi sono condotte secondo criteri definiti da gruppi di ricerca europei e validati da tempo. Un punto fondamentale dello studio Aism è che, per la prima volta, l’esame diagnostico verrà fatto in cieco: l’operatore periferico non saprà se la persona analizzata è affetta da sclerosi multipla o meno. Questo perché, trattandosi di un esame complesso, in cui entrano in gioco molte variabili, alcune dipendenti dall’operatore, è importante che l’esaminatore non sappia della malattia del paziente. Infine, a garanzia della certezza diagnostica, vi saranno tre “lettori” che riesamineranno i risultati, anch’essi ignari delle condizioni di salute dei volontari”.
Come avviene la formazione dei sonologi?
“Data la difficoltà del test, la formazione dei sonologi è un punto critico. Gli operatori seguiranno quindi i criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Inoltre abbiamo definito dei prerequisiti: chi fa lo studio deve avere un curriculum adeguato, un’esperienza pluriennale di sonologia e deve seguire dei corsi di formazione ad hoc. La Sinec e la Società interdisciplinare neurovascolare (Sinv) rilasceranno una certificazione nazionale affinché solo gli specialisti adeguatamente preparati possano partecipare allo studio. Molti di quelli che eseguiranno gli esami sono già stati formati presso la sede del professor Zamboni, alcuni stanno facendo il training presso la struttura da me diretta a La Spezia, altri a Reggio Emilia. Il fine è raggiungere una formazione che sia il più possibile standardizzata, perché una caratteristica fondamentale degli esami diagnostici è la loro riproducibilità: se faccio un esame radiografico del torace a Bari, a Napoli e a Milano, l’esito deve essere lo stesso”.
Quando e perché il professor Zamboni si è dimesso dal comitato scientifico dello studio Aism?
“Il professore Zamboni si è ritirato dallo studio quando ormai il protocollo era stato disegnato; lui stesso ha partecipato alla stesura. E, personalmente, non credo abbia nulla da ridire al riguardo, visto che il protocollo è stato riprodotto quasi identico nello studio Brave Dreams, di cui Zamboni è ‘principal investigator’. Il disaccordo riguarda gli operatori: Zamboni riteneva troppo alto il loro numero. Ma, ribadisco, la logica scientifica vuole che qualunque test diagnostico sia riproducibile, indipendentemente da quante persone conducono gli esami. Non esiste il concetto di un esame che possa essere condotto da un solo esperto, o da pochi. Il problema è strettamente legato alla numerosità del campione: per dimostrare l’esistenza di una associazione tra CCSVI e SM occorre un numero di pazienti molto ampio, statisticamente valido; di conseguenza, occorre che gli esaminatori siano in numero proporzionale. É impensabile che tutti i 2.000 partecipanti vengano diagnosticati solo dal professor Zamboni e da pochi altri esperti”.
Può spiegarci le differenze tra lo studio Aism e il Brave Dreams?
“Una prima differenza sta negli obiettivi: il primo vuole verificare la presenza e la frequenza della CCSVI nella sclerosi multipla, nelle persone affette da altre patologie neurologiche e in quelle sane, il secondo vuole appurare se l’intervento di disostruzione di una vena stenotica tramite angioplastica comporti o meno un beneficio nei pazienti con sclerosi multipla. Entrambi sono randomizzati e in cieco, ma Brave Dreams è uno studio di intervento, quello dell’Aism, invece, è uno studio osservazionale”.
Trattandosi di uno studio di intervento non dovrebbe partire dopo l’eventuale dimostrazione della correlazione tra CCSVI e sclerosi multipla?
“A rigor di logica dovrebbe essere così. Ma di fronte a una forte richiesta da parte dei malati di avere accesso al trattamento, pur in assenza di prove sull’associazione tra le due patologie, e per motivi che potremmo definire di salute pubblica, si è deciso di inserire queste persone all’interno di uno studio scientifico rigoroso. Brave Dreams, infatti, è stato approvato dal comitato etico dell’azienda di Ferrara e al momento stanno per essere identificati i centri che vi parteciperanno”.