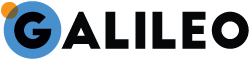Luciano Maiani, fisico e attuale presidente della Commissione Grandi Rischi, ha appena annunciato le sue dimissioni, cui sono seguite quelle di tutti gli altri vertici dell’ente. La notizia è l’ultimo atto della bagarre mediatica scoppiata dopo la sentenza del tribunale de L’Aquila, che ha condannato a 6 anni di carcere i componenti della Commissione al tempo del terremoto abruzzese del 2009. Si tratta di Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Bernardo de Bernardinis, Giulio Selvaggi, Claudio Eva e Gianmichele Calvi, giudicati responsabili di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose per aver dato alla popolazione “informazioni inesatte, incomplete e contraddittorie” sull’effettivo rischio di nuove scosse dopo lo sciame che precedette il forte sisma del 6 aprile. In particolare, i giudici sostengono che la riunione della commissione fu “approssimativa, generica e inefficace in relazione alle attività e ai doveri di prevenzione e prevenzione”.
La sentenza ha scatenato una lunghissima eco di proteste, ancora lontana dal placarsi. Anche a non voler entrare nel merito della decisione dei giudici e aprire l’inevitabile discussione su dietrologie e ingerenze politiche, alcune domande sorgono spontanee. È giusto attribuire tutta la colpa agli scienziati? Si poteva effettivamente dire o fare qualcosa di più? La vicenda è molto complessa: per capirne di più abbiamo sentito il parere di Giancarlo Sturloni, docente di comunicazione del rischio alla Scuola Internazionale di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste.
Cosa è successo esattamente all’Aquila?
Il 31 marzo 2009, una settimana prima del sisma, si sono riuniti gli esperti della Commissione Grandi Rischi, convocati da Bertolaso, per discutere dell’opportunità o meno di allertare la popolazione sul rischio di nuove scosse. Dalla riunione è emerso che non si correvano particolari pericoli, e quindi non era necessario dare l’allarme o evacuare la zona. Purtroppo, non è stato così.
Dove hanno sbagliato, se hanno sbagliato, gli scienziati della commissione?
Hanno gestito male, a mio parere in completa buonafede, la comunicazione del rischio, perché hanno omesso l’informazione più importante, e cioè che i terremoti non si possono prevedere, e dunque non è neanche possibile escluderli con certezza. In un certo senso, in questa vicenda è venuto meno il diritto dei cittadini a essere informati in modo corretto. Le commissioni non possono permettersi di banalizzare la gravità di un problema, non possono nascondere le incertezze. Ci tengo a precisarlo: questo non è un processo alla scienza; è – casomai – un processo alla cattiva comunicazione. È un settore su cui, in Italia, siamo purtroppo ancora completamente impreparati, anche perché vige ancora l’idea, un po’ paternalistica, che la cittadinanza non sia in grado di gestire correttamente le informazioni e prendere decisioni in autonomia.
Come bisognerebbe gestire allora situazioni di allerta come quella del 2009?
Con una comunicazione del rischio trasparente e onesta. Gli scienziati dicono quello che sanno e quello che non sanno; quali sono le probabilità e qual è l’errore sulla loro stima, quando si hanno questi dati. Anche a costo di sembrare impreparati. Basta pensare a quello che è recentemente successo nel caso delle pandemie: il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Margaret Chan, ha recentemente ammesso che la scienza non sa come evolve un virus nelle prime settimane di diffusione. Non significa non preoccuparsi del problema: è semplicemente dire la verità e lasciare la cittadinanza libera di decidere in base alle informazioni ricevute.
Pensa che cambierà qualcosa dopo la sentenza?
Mi auguro di sì; purché, per scaricarsi da ogni responsabilità, non si ricada nell’estremo opposto, quello dell’allarmismo facile. Penso per esempio a quello che è già successo nel caso del terremoto in Emilia, quando già si sapeva del processo in corso per i fatti dell’Aquila, e si parlò di allerta eccessiva lanciata dagli scienziati. La strada giusta è una sola: dire semplicemente, onestamente, la verità.
Credits immagine: midiclorian photo maker/Flickr