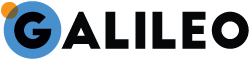Chi decide le priorità nella ricerca scientifica? Quali dovrebbero essere i rapporti tra scienza, politica e opinione pubblica? Come si passa da un dato scientifico, con tutta la sua provvisorietà, a una decisione normativa che lo riguarda? Per esempio dal riscaldamento globale a una politica dell’energia che eventualmente lo riduca? In poche parole, come si “governa” la scienza?Sono questi i temi al centro della prima serie di incontri di Spoletoscienza (Palazzo Ancaiani, Piazza della Libertà, 29-30 giugno 2002), il ciclo di convegni promosso ormai da quattordici anni dalla Fondazione Sigma Tau a margine del Festival dei Due Mondi. Nella città umbra si sono confrontati alcuni dei protagonisti del panorama scientifico internazionale. Tra questi, Bjorn Lomborg, autore del libro The skeptical environmentalist che ha sollevato una grande polemica tra le associazioni ambientaliste, riviste di settore e gruppi di interesse. Lomborg, direttore dell’Environmental Assessment Institute danese ed ex membro di Greenpeace, sostiene che, secondo i dati internazionali più aggiornati, la situazione ambientale del nostro pianeta non è così catastrofica come sembra, anzi in molti casi è migliorata. È necessario quindi decidere un’agenda ambientale e politica corretta dal punto vista scientifico. Sulla stessa lunghezza d’onda è intervenuto Henry Miller, fondatore dell’Ufficio delle biotecnologie della Food and Drug Administration americana, affermando che troppo spesso, durante la sua opera “sul campo” nella valutazione dei rischi delle nuove tecnologie, la sfera emotiva dell’opinione pubblica prende il sopravvento rispetto ai giudizi degli esperti; Roger Pielke del Center for Science and Technology Policy Research di Boulder in Colorado ha però rilevato come sia proprio la scienza attuale a correre gravi pericoli. Nel “triangolo di ferro” scienza-politica-gruppi di pressione analizzato da Pielke, la ricerca scientifica è un vertice che a fronte delle risorse a essa destinate dall’autorità politica è incaricata di trovare soluzioni per i problemi sociali. I gruppi di pressione infine utilizzano i dati scientifici per i propri obiettivi. Paul Anand ha concluso raccontando la sua esperienza come esperto nella valutazione del rischio nel caso dell’epidemia di Bse in Gran Bretagna, una vicenda che lo ha portato al centro di complesse preoccupazioni sanitarie, economiche, ambientali, scientifiche, etiche e politiche.Nella giornata di domenica, i temi discussi il giorno precedente hanno quasi preso forma attorno al caso delle cellule staminali, dove la diverse prospettive del ricercatore (Angelo Vescovi), del magistrato (Amedeo Santosuosso), della sociologia della scienza (Agnes Allansdottir), dello storico delle scienze biomediche (Gilberto Corbellini) hanno evidenziato la delicatezza della ricerca di frontiera dove ogni questione complessa ha rilevanti implicazioni multidisciplinari.In effetti, come ha affermato Pino Donghi, segretario generale della Fondazione Sigma-Tau, presentando la manifestazione “il governo della scienza è oggi la questione delle questioni. Ma negli incontri di luglio parleremo anche di concetti come ‘differenza’ e ‘identità’. Spoletoscienza è infatti da sempre un laboratorio dove mettere a confronto linguaggi e prospettive diverse, favorendo un processo di contaminazione che riteniamo fondamentale”.L’edizione di quest’anno, infatti, non ha un tema unico, ma è articolata in una serie di incontri attraversati da un filo conduttore: la diversità del fatto scientifico, un processo distintivo che permette ai risultati della scienza di affermarsi e di emergere all’attenzione del pubblico.Spoletoscienza proseguirà fino al 14 luglio, ecco il programma dei prossimi incontri.Il programma dell’edizione 2002